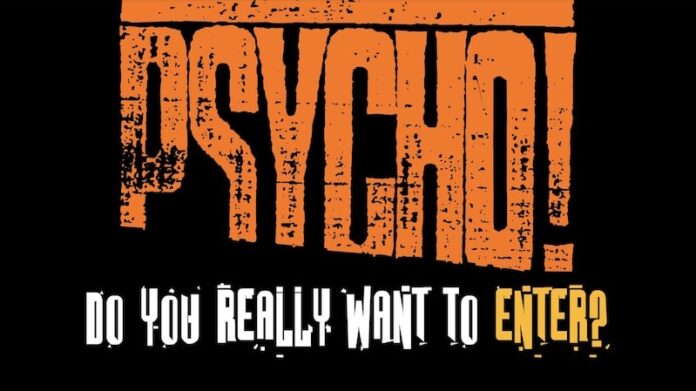Regia: Gus Van Sant
Regia: Gus Van Sant
Anno: 1998
La segretaria Marion Crane ruba 400.000 dollari e fugge in California inseguendo un fidanzato che non può sposare. Smarrita la strada, dovrà passare la notte in un motel gestito da uno strano locandiere: Norman Bates.
In un suo celebre saggio, il professor Gianni Canova parlava di Psycho (1998) di Gus Van Sant come di un film di cui “paradossalmente, si potrebbe scrivere anche senza averlo visto”, in quanto “conta più per le questioni che pone che per quello che è” (il remake shot-for-shot di Psyco, 1960, di Alfred Hitchcock).
Per chi è interessato, vale la pena (ri)vederlo per scoprire il perché. Operazione post-moderna per eccellenza, puramente teorica e concettuale, che procede per accumulo di innesti, cortocircuiti e citazionismo portati al parossismo, l’opera di Gus Van Sant ha spiazzato e infastidito i più.
Tutti a chiedersi se avesse senso riprodurre pedissequamente un’opera formalmente perfetta come Psyco, ricalcata in (quasi) ogni singola inquadratura, dialogo e sviluppo narrativo, senza tentare in alcun modo di reinterpretare un classico con una nuova sensibilità.
Per Gus Van Sant si trattava semplicemente dell’unica soluzione rimasta in epoca di crisi del visibile. In cui il cinema, nell’implicita tesi del regista, sembra aver ormai perso la capacità di aprire sguardi/squarci nuovi e inattesi sul reale, senza riuscire a produrre più nulla di realmente innovativo e significativo.
Van Sant lo esplicita riprendendo Bates mentre si masturba (elemento assente in Hitchcock) spiando Marion dalla fessura nel muro. Non potendo più ricreare un autentico pathos morboso, istituire un’ossessione voyeuristica, “un’emozione cinematografica di massa” (come la intendeva Hitchcock), allo Psycho di Van Sant, proprio come per Bates, non resta che “masturbarsi” simbolicamente, trastullandosi con i fantasmi del “corpo” filmico di riferimento (il film del 1960) che non può possedere e fare proprio. Se non tramite un’adesione passiva, uno sguardo derivativo.
Quindi, c’è spazio solo per una schizofrenica e al tempo stesso lucidissima coazione a ripetere lo schema. Costruendo un calco ingessato, un “clone” (come lo definiva Canova), un deliberato plagio stilistico, pressoché totale, del prototipo hitchcockiano, esibito fin dall’incipit. Dove un piccolo elemento funziona da legame intertestuale tra le due opere, per chiarire la prospettiva del film.
Nella camera da letto, a fianco dei personaggi, la m.d.p. scopre su un tavolino il dettaglio fugace di una mosca posata su alcuni sandwich farciti. Sono forse gli stessi che Norman Bates, nel film originale, offriva a Marion Crane? Sono i resti (avariati o conservati perfettamente come gli uccelli imbalsamati?), le briciole/frammenti del film del 1960 ora re-installate (riscaldate?) dal regista? Avvolte nel ronzio della stessa mosca che compare nel finale hitchcockiano tra le dita di Bates?
Forse, allora, lo scarto tra i due film si salda proprio nella sequenza immediatamente precedente, quella iniziale: la ripresa aerea in continuità, dall’esterno all’interno dell’edificio, senza stacchi, come lo stesso Hitchcock l’aveva concepita in origine, che dallo skyline dei grattacieli di Phoenix penetra fin dentro la camera d’albergo.
La traiettoria della cinepresa, mutuata dal maestro, è ora leggibile come un libero volo della mosca che compare subito dopo. La quale, fuoriuscita idealmente dal finale del film hitchcockiano, si appresta ora a (ri)entrare dall’incipit di quello del 1998, attraverso la stessa finestra/apertura offerta dall’originale (la stanza dei due amanti).
 Il film di Van Sant, così, si “appoggia” al suo modello proprio come la mosca si posa sul sandwich. Entrambi irresistibilmente attratti dai residui di un corpo (pro-)filmico avvertito come familiare e straniante al tempo stesso: quei panini che il Bates hitchcockiano serviva elegantemente su un vassoio. Ora divenuti insipide cibarie da fast food, accartocciate insieme alle patatine fritte. Fuor di metafora, lo Psyco di Hitchcock, con i suoi inconfondibili segni e icone, si è trasformato in oggetto-pop (la fotografia di colori saturi e accesi con effetto technicolor patinato) per un consumo indifferenziato e indifferente. Prodotto di massa (amorfa) ormai replicabile da chiunque.
Il film di Van Sant, così, si “appoggia” al suo modello proprio come la mosca si posa sul sandwich. Entrambi irresistibilmente attratti dai residui di un corpo (pro-)filmico avvertito come familiare e straniante al tempo stesso: quei panini che il Bates hitchcockiano serviva elegantemente su un vassoio. Ora divenuti insipide cibarie da fast food, accartocciate insieme alle patatine fritte. Fuor di metafora, lo Psyco di Hitchcock, con i suoi inconfondibili segni e icone, si è trasformato in oggetto-pop (la fotografia di colori saturi e accesi con effetto technicolor patinato) per un consumo indifferenziato e indifferente. Prodotto di massa (amorfa) ormai replicabile da chiunque.
Seguendo la stessa “ricetta” alla lettera, miscelando i medesimi “ingredienti” dell’archetipo, senza però la carica originaria (irrimediabilmente perduta), non può che scaturire un prodotto insapore, indigesto, inevitabilmente “scaduto”. Gus Van Sant ne è pienamente cosciente. Il suo scopo è proprio questo: non rifare il “totem” Psyco in atteggiamento di adorazione e omaggio. Ma, al contrario, problematizzare, svuotare, rendere inutile l’azione fagocitante operata sul classico dal nuovo film.
Psycho di Gus Van Sant gratta la crosta/superficie dello Psyco hitchcockiano, ingozzandosene poi alla nausea, fino a scoppiare, implodere. Trovandosi satollo e intorpidito come una mosca intontita dal troppo cibo. Similmente, la stessa, gravosa sensazione di noia e di “già visto” che può affossare la pazienza dello spettatore amante dell’opera originale. Reazione consapevolmente e beffardamente perseguita dal regista.
Film freddo, piatto, perfino respingente, ma che contiene un’audace sfida cinematografica, una riflessione radicale e provocatoria sullo statuto dell’arte filmica e dell’immagine.
Martedì 17 settembre h. 21.00 su Top Crime (a seguire, Psyco, 1960, di Alfred Hithcock)